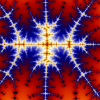Nel numero 7 di Figure Emergenti intitolato “Attenti al lupo”, all’interno della sezione Esperienze, troverete l’articolo “Spostare i confini: verso altri modi di intendere l’alterità” dedicato al lavoro in Senegal che da qualche anno porto avanti con l’antropologo medico Angelo Miramonti e che rappresenta un assaggio della ricerca qualitativa condotta nel 2023 presso il centro psichiatrico universitario Moussa Diop di Dakar sul tema della migrazione di ritorno.
La narrazione della nostra esperienza cerca di coniugare il significato del rimpatrio dei migranti senegalesi con l’ospedalizzazione all’interno di un servizio psichiatrico di Dakar e si costruisce intorno ad alcuni fuochi centrali del processo terapeutico e della presa in carico del malessere psicologico.
Lo scritto in questione è un avvicinamento a un modo diverso di interpretare la malattia mentale e la cura ed è un primo tentativo di traduzione di alcuni termini chiave propri dell’etnopsichiatria e del transculturalismo nel linguaggio della Gestalt.
In che modo le nozioni fondanti la nostra prospettiva clinica possono contribuire alla costruzione di una dottrina che tenga conto della complessità culturale?
Quale può essere l’esperienza di un terapeuta che si pone come ambiente di fronte all’alterità dell’altro?
Su quali basi poggia l’incontro quando le soggettività corrispondono a costruzioni umane così aliene?
Ogni interrogativo apre a nuove prospettive.
Le domande guidano la nostra esplorazione attraverso saperi differenti, alla ricerca non già di una risposta o di una risoluzione, ma piuttosto verso l’accompagnamento a una comprensione più profonda che possa essere preludio di una visione teorica maggiormente articolata e polimorfa.
Il nostro sguardo complementarista, costruito dall’antropologia culturale e dalla terapia della Gestalt, è spinto da un interesse e da una curiosità che mirano a non confinare la conoscenza in costrutti già noti e consolidati ma puntano all’apertura e alla flessibilità per favorire la nascita di nuove definizioni e letture interpretative.
Nell’attesa di condividere su questa rivista i risultati della nostra nuova ricerca terminata in questi giorni (Marzo 2025) all’interno della clinica psichiatrica Moussa Diop di Dakar e del Centro psichiatrico Émile Badiane di Ziguinchor, condivo con voi il Prologo del libro “Amina. Ritratto di una donna abitata dagli spiriti ancestrali” che Angelo Miramonti ha scritto qualche anno fa e che raccoglie i risultati di una ricerca etnografica condotta in Senegal a partire dalla vita di Amina, una donna di etnia Lebu posseduta dagli spiriti del suo lignaggio.
In calce trovate i riferimenti all’articolo e al libro in questione che purtroppo non è stato possibile pubblicare integralmente, su FigureEmergenti. Speriamo che questa premessa vi faccia venir voglia di leggere per intero i contenuti e che vi accompagni sempre di più verso un modo differente di significare la malattia e la guarigione.
Il corpo della persona colpita da una sofferenza che la cultura occidentale definisce una “malattia psichiatrica” in Senegal diventa spesso il terreno su cui si incontrano due differenti sistemi di cura: quello della biomedicina occidentale che racchiude in uno spazio intrapsichico il disagio e la sofferenza mentale e quello della medicina tradizionale che apre all’invisibile e al mondo animista dei rab, spiriti ancestrali, origini e cause del malessere.
Le due differenti strade verso la guarigione offrono eziologie e pratiche molto diverse. Amina sceglie, nel racconto che Miramonti fa nel suo articolo, di farsi aiutare da un guaritore tradizionale e di affidarsi al culto dell’Ndöp nella speranza di curare ciò che le dà tormento da anni.
Il rituale di possessione organizzato in cerimonie che coinvolgono principalmente le donne (la presenza di maschi adulti tra il pubblico è molto più marginale) di un intero villaggio o di un quartiere, si articola in momenti collettivi, a tratti spettacolari, attraverso suoni di tamburi, stati di trance e sacrifici di animali e nasce con l’obiettivo di invitare i rab che hanno preso possesso della persona a manifestarsi per arrivare non tanto ad una loro esorcizzazione, ovvero una loro espulsione o rimozione dal corpo, quanto a una loro integrazione mediante la costruzione di una relazione di alleanza simbolizzata dalla costruzione di un altare domestico.
Se nella pratica dell’esorcismo si opera una separazione netta tra l’umano e il divino (si pensi al conflitto tra Dio e il demonio nella cultura cristiana, teso a risolversi con l’estromissione di Satana dal corpo del posseduto) in linea con una visione dualistica della cultura occidentale, nella pratica dell’adorcismo dei culti Ndöp invece si supera il concetto di polarità e ci si rifà all’idea di olismo attraverso l’unità tra il mondo umano e quello spirituale.
Così come nella teoria della Gestalt ci si appoggia alla definizione di campo organismo ambiente per definire la relazione dinamica e inseparabile dell’individuo con l’ambiente, enfatizzando il fatto che l’esperienza possa essere compresa solo come un tutto o una “gestalt” che emerge dall’interazione tra organismo e ambiente, allo stesso modo l’adorcismo abbraccia una visione integrata e fluida delle componenti materiali e spirituali che definiscono la persona fuggendo una visione manichea e frammentata del fenomeno.
Lo spirito chiama e si fa sentire, aggredisce la persona creandole disturbo e tiranneggiandola, cerca di attirare l’attenzione e manifesta la sua presenza attraverso il corpo del malato, mediante quelli che la biomedicina definisce i sintomi psichici e comportamentali.
L’intervento di un guaritore tradizionale all’interno di uno spazio cerimoniale collettivo permette in un primo momento l’identificazione e la nominazione di questi génies che in questo modo possono essere riconosciuti e, in un secondo momento, la costruzione di una mediazione e di un dialogo che possano portare a stabilire un patto durevole con l’essere invisibile che riceverà un culto permanente e in cambio donerà fortuna e protezione.
La conseguente conciliazione porterà a una graduale remissione dei sintomi e a un senso di liberazione della persona, che si riconoscerà come parte di una “confraternita” di possedute.
La storia di Amina e del suo percorso di guarigione ci permette di fare un passo ulteriore all’interno di un mondo dove la malattia mentale assume sfumature e tonalità diverse aprendo ancora a interrogativi sulla nostra pratica clinica.
Non potendo pubblicare qui il libro o l’articolo
Spero che la lettura di questo prologo così chiaro e coinvolgente che apre il libro di A. Miramonti possa far nascere in voi nuove curiosità sulla tridimensionalità dell’essere umano e su come stereotipi, pregiudizi e incomprensioni interculturali possano talvolta, al di fuori della nostra consapevolezza, erroneamente guidare le nostre scelte cliniche e il nostro operato psicoterapico all’interno del setting di lavoro.
Monica
Prologo. Tamburi nella notte
di Angelo Miramonti
3 agosto 2014, sabato, ore 22. Sono arrivato a Dakar due settimane fa, lavorerò qui per qualche anno, non so ancora per quanto. Dakar non è nuova per me, ho già vissuto qui per un anno, nel 2003. Da due giorni ho trovato un appartamento a Yoff, un quartiere periferico di Dakar, a cento metri da un villaggio di pescatori dell’etnia Lebu. Il villaggio è un dedalo di vicoli coperti di sabbia, dove non entrano le auto e si cammina lentamente, sprofondando a ogni passo. Il centro abitato è disteso lungo l’oceano, su un tratto di spiaggia della penisola di Dakar. Nel 1444 i portoghesi “scoprirono” questa penisola sull’estremità occidentale dell’Africa, dove secoli dopo sorse la capitale del Senegal. Ogni notte da questa spiaggia partono le piroghe dei pescatori Lebu, un popolo venuto dall’interno secoli fa, che si insediò sulla costa e divenne pescatore e agricoltore. Quello davanti al villaggio di Yoff è uno dei mari più pescosi del mondo: la parte di Oceano Atlantico che lambisce il Senegal e la Mauritania.
Stasera i miei nuovi colleghi mi hanno invitato a raggiungerli in città per una cena. Esco di casa per cercare un taxi. Il mio appartamento si trova in un edificio che dà su un piazzale asfaltato con alcuni ristoranti, dove circolano auto ad ogni ora del giorno e della notte; lì posso trovare un taxi e arrivare in centro. È notte, guardo il piazzale semibuio cercando una macchina gialla. Lo sguardo vaga verso gli edifici scuri del villaggio, a un centinaio di metri dal piazzale. Mentre osservo quella massa scura, ripenso a quando, undici anni fa, attraversavo il villaggio di notte per andare a telefonare alla mia famiglia in un call centre dall’altra parte. Ripenso a quegli istanti lontani e sento il desiderio di attraversare di nuovo il villaggio, immerso nella notte. La nostalgia mi chiama verso quegli edifici semibui e quella sabbia profonda, dove anni fa camminavo lentamente, per raggiungere un negozio ormai scomparso. Sento un richiamo inspiegabile a percorrere di nuovo quei vicoli di notte, quando le luci giallo ocra dei lampioni filtrano in mezzo alle case e colorano i muri, la sabbia e la gente di un giallo intenso, irreale. Un taxi si ferma di colpo davanti a me e mi offre di salire. Mi scuoto dai miei ricordi, esito per un attimo: è la cosa giusta da fare, prendere quel taxi e andare in città, attraverserò il villaggio un’altra volta, tanto sarò qui per anni.
Ancora oggi non ricordo, o non so spiegarmi, perché dissi di no a quel taxista e decisi di andare a cercare un taxi dall’altra parte, attraversando a piedi il villaggio. Volevo rivivere le emozioni di undici anni prima, vedere le donne che arrostiscono le arachidi nella sabbia arroventata dal fuoco, i bambini che giocano e gli uomini in abiti lunghi che discutono, seduti davanti alle porte. Il taxi riparte senza di me.
Mi incammino verso il villaggio, mi accorgo che sto entrando quando sento l’asfalto che diventa irregolare, sconnesso, e infine sento la sabbia cedere sotto i piedi a ogni passo. Con l’asfalto finisce anche la Dakar moderna e comincia la terra dei Lebu, un’etnia fiera della sua identità e dei suoi culti tradizionali, che si è convertita all’Islam solo all’inizio del Novecento e conserva molte delle sue credenze ancestrali. È agosto, fa un caldo asfissiante. C’è tanta gente per strada, signore che vendono, bambini e famiglie intere sedute accanto a mucchi di ghiaia per costruzioni. Imbocco il vicolo che anni fa percorrevo per andare al call centre. I muri si fanno più vicini, la luce dei lampioni piove dall’alto e inonda i muri; c’è un’immagine bianca di Sëriñ Touba dipinta su un muro, che sotto a quelle luci diventa color ocra. Imbocco il vicolo che porta all’altro piazzale, dove spero di trovare un taxi. Mentre cammino, sento in lontananza un rullo assordante di tamburi. Continuo a camminare, il frastuono diventa sempre più forte. Mi inoltro nel vicolo, cinquanta metri più avanti vedo un capannello di persone che si accalca intorno a una stretta apertura in un muro rosso scuro, a pochi metri da dove una volta si trovava il mio call center. Mi fermo e domando a un ragazzo: “cosa succede?”. Mi risponde: “è lo Ndöp”.
Quella parola mi colpisce come un pugno: ho studiato il rituale di possessione Ndöp presso i Lebu qualche mese fa, in un libro di un mio professore. Ora lo Ndöp è qui, dietro a una fessura nel muro e una calca di gente curiosa. Ho paura, rispetto e pudore, non vorrei chiedere, ma la domanda esce dalla mia bocca prima che pensi a quel che sto dicendo, quasi contro la mia volontà: “posso andare a dare un’occhiata?”. Mi pento di averlo chiesto appena ho finito di dirlo, mi aspetto una risposta offesa, sdegnata, o magari un gentile diniego: sono cerimonie profondamente radicate nella cultura Lebu, non permetteranno a un toubab, a un bianco, di assistervi. La risposta arriva inattesa, seducente e inquietante come il regalo di uno sconosciuto: “non c’è problema”. Mi ha detto che posso andare. Attraverso la feritoia nel muro, facendomi largo nella calca e arrivo in uno spiazzo interno, cinto di mura e coperto di sabbia. Ci sono circa duecento persone sedute intorno a uno spazio circolare, il rullo dei tamburi è assordante. Su un lato dello spiazzo, c’è un’intera troupe di griot, l’antica casta di batteurs, suonatori di tamburo che si tramandano i saperi di padre in figlio. Suonano a un ritmo rapido e ripetitivo, un sacerdote intona un canto e la gente risponde in coro. Mi sembra di capire che stanno invocando uno spirito perché venga nell’assemblea. La gente mi guarda, sono l’unico bianco di quelle duecento persone; nessuno protesta, tutti sono presi dalla cerimonia, rapiti da quella “festa degli spiriti” che sono i riti di possessione dei Lebu. In pochi minuti dimentico il mio appuntamento in città e, senza accorgermene, rimango due ore a osservare quella cerimonia che avevo studiato sui libri, mesi prima. Alcune donne ballano davanti ai griot, cadono in trance, tremano e si agitano, sono sostenute a fatica da altre donne, e dopo alcuni minuti si accasciano sulla sabbia, prive di sensi. Il sacerdote intona diversi canti per invocare gli spiriti, perché vengano e possiedano le loro iniziate. Altre donne ballano davanti ai griot, tremano e si agitano in trance, fino a cadere a terra. Sono le donne che hanno stretto un’alleanza con uno dei geni invocati dai canti. Il loro spirito è venuto e le ha prese, le ha fatte danzare fino a farle cadere in trance e le ha fatte accasciare al suolo, con gli occhi chiusi e la faccia sudata coperta di granelli di sabbia. Le danze di possessione avvengono sempre sulla sabbia anche per questo: per attutire le cadute delle possedute.
Verso mezzanotte, i tamburi rallentano fino a fermarsi, le donne cadute vengono rialzate dalle officianti e la gente comincia ad andarsene. Il giovane che mi ha lasciato passare mi dice: “allora? Ti è piaciuto? Torna domani mattina, sacrificheremo un bue in onore di Samba Diop, lo spirito alleato di tante donne, qui nel villaggio”. Gli dico che tornerò.
Non presi mai quel taxi per andare in città. Rimasi fino alla fine della cerimonia e tornai a casa pensieroso, con le scarpe piene di sabbia. Quella sabbia che si appiccicava ai visi sudati delle possedute entrava simbolicamente in casa mia, a trecento metri dal luogo del culto, in un appartamento della Dakar moderna, abitato da un bianco appena arrivato, vicino a una spiaggia turistica e a due chilometri dall’aeroporto internazionale. Se avessi preso quel taxi davanti a casa, sull’asfalto della Dakar moderna, questo scritto non sarebbe esistito.
Mi sono dato tante spiegazioni sul perché decisi di attraversare il villaggio quella notte: la nostalgia, il desiderio di rivedere il villaggio di notte, le arachidi tostate nella sabbia arroventata, i vicoli e la luce che bagna ogni cosa dall’alto. La verità è che non lo so perché non presi quel taxi. Quel giorno una voce misteriosa mi ha chiamato verso il villaggio, verso quei vicoli angusti e i culti ancestrali dei Lebu, “tètes de poisson”, come dicono i vicini Wolof, teste di pesce, orgogliosi, testardi, invasati. Quel giorno, una voce mi ha chiamato verso quel buio colorato di giallo e verso quei misteriosi tamburi nella notte.
______
4 agosto 2014, domenica, ore 15. Sono passate poche ore dal mio primo incontro con lo Ndöp. Sono tornato alla cerimonia per assistere al sacrificio in onore di uno spirito ancestrale: Samba Diop. Tutto il villaggio ha raccolto offerte per comprare il bue del sacrificio. Arrivo nello stesso spiazzo della sera prima, mi accorgo che è circondato da strutture di cemento sopraelevate che ieri sera non avevo notato, scheletri di stanze di cui non hanno ancora costruito le porte e le finestre, cubi vuoti e grigi, leggermente più alti dello spiazzo, dove la gente è stipata a guardare. La cerimonia inizia. Sono ancora l’unico bianco, ma riconosco il giovane della sera prima. Almeno una persona la conosco. Osservo la cerimonia, vedo per la prima volta sgozzare un bue e raccogliere il suo sangue in un catino. I batteurs incominciano a suonare, il sacerdote intona un canto e le danze iniziano. Passano varie ore. Verso sera, la cerimonia volge al termine, i griot smettono di suonare e i presenti cominciano a defluire. È ora di andarmene. Incomincio a farmi largo, passo sotto a una di quelle stanze in costruzione che la gente usa come tribune, cerco un varco tra la folla. A un tratto sento una voce dietro di me, che mi chiama dall’alto, da uno di quei cubi grigi, e mi dice: “buongiorno”. Mi giro: è una signora su cinquant’anni, lo sguardo vivo, profondo, benevolo, che mi guarda incuriosita. “Sei un bianco, cosa ci fai qui?”. Sono un po’ intimidito, ma decido di dirle solo la verità: “sono appena arrivato a Dakar, ieri sera sono passato per caso nel villaggio e mi hanno detto che c’era una cerimonia di Ndöp, ho chiesto di assistere e mi hanno detto che potevo. Dopo la cerimonia mi hanno invitato a tornare oggi per il sacrificio e sono tornato”. Continua a fissarmi con curiosità: “E perché ti interessano queste cose?”. “Le ho studiate all’università, in un libro di un mio professore, quando mi hanno detto che c’era una cerimonia ho pensato di venire a vedere di persona quello che avevo letto sui libri. Ho chiesto il permesso e mi hanno lasciato passare”. “Sì, ma perché studi le nostre cose sui libri?”. “Perché mi interessano molto, da me non ci sono, almeno non così, e vorrei conoscerle”. Il suo sguardo è sempre benevolo, ma diventa più deciso: “se vuoi conoscerle segnati il mio numero e chiamami stasera, voglio raccontarti quello che mi è successo. Mi chiamo Amina, abito nel villaggio, gli spiriti mi seguono e non mi danno pace. Sono qui a onorare uno di loro, che vive con me da molti anni. Se mi vieni a trovare ti racconterò cosa mi è successo da quando gli spiriti mi hanno presa”. Annoto il suo numero.
La chiamo il giorno dopo e concordiamo una visita la sera seguente. Da quel giorno in cui ho sentito quella voce che mi chiamava da un cubo di cemento sono stato casa sua decine di volte, da agosto 2014 a settembre 2017. Grazie ad Amina ho potuto incontrare griot, sacerdoti e sacerdotesse del culto Ndöp e varie possedute. Con lei ho assistito a una ventina di cerimonie di possessione, l’ho accompagnata in quattro cerimonie private e in altri momenti della sua biografia recente, in cui le sue vicende famigliari e la sua irripetibile esperienza di incontro con gli spiriti ancestrali si intrecciano, fino a confondersi.
Un estratto della ricerca è disponibile gratuitamente qui:
https://www.ledijournals.com/ojs/index.php/antropologia/article/view/1737
È possibile leggere l’intera ricerca qui:
https://www.amazon.it/Amina-Ritratto-abitata-spiriti-ancestrali/dp/0244744998